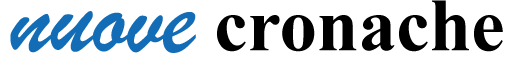Il cambio climatico prosegue il suo corso inarrestabile, incendiando grafici e report con cifre sempre più allarmanti. Aprile 2024 è stato certificato come il mese di aprile più torrido a livello globale, scalzando dalla vetta del podio tutti i precedenti record, dal lontano XIX secolo ad oggi, secondo quanto rivelato dal servizio meteorologico europeo Copernicus.
Questa perturbazione termica non rappresenta un episodio isolato, bensì l’ennesimo capitolo di un trend che sta assumendo connotati sempre più preoccupanti. Infatti, questo aprile ha sancito l’undicesimo record consecutivo di calore, un fenomeno mai registrato con questa continuità nella storia meteorologica moderna.
Dettagliando ulteriormente, il mese ha esibito una temperatura media globale dell’aria in superficie di 15,03 gradi Celsius, segnando un aumento di 0,67°C rispetto alla media del periodo tra il 1991 e il 2020, e di 0,14°C al di sopra del precedente record segnato nell’aprile del 2016. Oltre a ciò, il dato più inquietante è che l’incremento termico rispetto alla media dell’era pre-industriale (1850-1900) è stato di 1,58°C.
In Europa, il quadro non è meno grave. Il continente ha registrato una temperatura media per il mese di aprile che supera di 1,49°C la normativa triennale 1991-2020, rendendolo il secondo aprile più ardente mai misurato.
Ma il segnale più allarmante giunge dall’osservazione a lungo termine: l’ultimo anno solare ha visto la temperatura media globale elevata di 0,73°C rispetto alla media 1991-2020 e di ben 1,61°C rispetto ai livelli pre-industriali. Un dato che suona come un campanello d’allarme rispetto agli obiettivi stipulati nell’Accordo di Parigi, in primis quello di contenere l’aumento delle temperature globali ben al di sotto dei 2°C, puntando agli ambiziosi 1,5°C.
Le implicazioni di questa escalation termica sono multiformi e vanno dall’accelerazione dello scioglimento dei ghiacciai alla frequenza sempre maggiore di eventi meteorologici estremi, che spingono sistemi ecologici e agricoli già fragili oltre i loro limiti di resilienza.
Parallelamente, le proiezioni non sono edificanti. Una ricerca recente del Politecnico di Milano, commissionata dalla società energetica Engle, indica che l’Italia, responsabile dell’1,7% delle emissioni globali di gas serra e membro del G7, sarà ben lontana dal raggiungere i target di riduzione delle emissioni fissati per il 2030 dall’Unione Europea.
Questo scenario pone riflettori accesi sulle politiche ambientali e sulle azioni di mitigazione che paesi e collettività internazionali devono urgentemente implementare. Se anche le nazioni più industrializzate faticano a rispettare i parametri di riduzione delle emissioni, quali speranze rimangono per una vera inversione di tendenza a livello globale?
Mentre i leader mondiali cercano di formulare risposte condivise, la comunità scientifica e i cittadini osservano con crescente apprensione. Il tempo a disposizione per adeguate azioni correttive si riduce rapidamente, quasi al ritmo dello scioglimento dei ghiacci polari, e la finestra d’azione si chiude sempre di più, oppressa dalle crescenti colonne di mercurio nei nostri termometri.