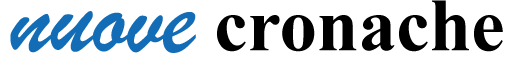La politica italiana, celebre arena di dibattiti accesi e di strategie retoriche articolate, negli ultimi decenni ha visto una trasformazione preoccupante nel tono e nel contenuto del linguaggio utilizzato dai suoi protagonisti. Questa metamorfosi non è stata caratterizzata solo da una maggiore informalità, ma anche dall’introduzione di un vocabolario scurrile e talvolta offensivo che ha suscitato non poche polemiche.
Fin dalla fine della prima Repubblica, la lingua italiana politica ha subito una lenta erosione del decoro tipico del parlare pubblico. Se nei primi anni ’90 un espressione fuori luogo poteva essere considerata una gaffe, come nel caso del Premier Lamberto Dini che sfuggì un irato “Eh cazzo!” in aula, oggi assistiamo a episodi ben più gravi e premeditati.
Il cambiamento del contesto comunicativo è palpabile. Ad esempio, nel 2020 la Camera dei deputati fu teatro di un evento che ha spostato sensibilmente il confine dell’accettabilità: durante un acceso scambio con la vicepresidente Mara Carfagna, il deputato Vittorio Sgarbi lasciò sfuggire una serie di epiteti estremamente offensivi, che culminarono con un’esclusione temporanea dall’aula. Questa scena non fu un’eccezione isolata, ma piuttosto un sintomo di una tendenza più ampia e radicata.
Silvio Berlusconi, figura iconica della politica italiana, fu protagonista di diversi episodi di questo tipo. Dai commenti ironici e pungenti, come il noto “più bella che intelligente” rivolto a Rosy Bindi, fino a scherzi di dubbio gusto con contenuti blasfemi – ricordiamo la barzelletta durante una visita post-terremoto a L’Aquila. Anche il suo commento sugli elettori di sinistra, trattati con disdain usando un termine decisamente forte, riflette una sorta di sfida alle convenzioni comunicative precedenti.
Non è un fenomeno circoscritto al centro-destra. Anche nel campo opposto si sono registrati momenti di franchezza estrema. Si pensi al No B-day del Popolo Viola o al noto Vaffa-day di Beppe Grillo, eventi che hanno utilizzato la provocazione e la parola forte come mezzi di mobilitazione politica e critica. E ancora, l’ex premier Massimo D’Alema che in due occasioni televisive ha risposto agli agguati giornalistici con risposte al limite dell’educazione.
Questo declino del decoro linguistico non è solo l’espressione dell’individualità o del carattere di alcuni politici, ma sembra essere diventato una strategia accettata e talvolta approvata per comunicare efficacemente con un elettorato sempre più disilluso e cinico.
In questo contesto, è lecito chiedersi quali siano le implicazioni di tali scelte comunicative. Il rischio è quello di scivolare verso una normalizzazione della volgarità, che non solo compromette la dignità del dibattito pubblico, ma mina anche la stessa efficacia della comunicazione politica. Invece di elevare il livello della discussione, questo stile può infatti generare isolamento e ulteriore disaffezione nei confronti della politica.
La polarizzazione può essere affrontata solo con un ritorno a un linguaggio che rispetti le differenze e dia precedenza al confronto di idee, piuttosto che allo scontro di personalità. La speranza è che i leader politici futuri riconoscano la responsabilità che comporta parlare in pubblico e optino per un registro che, pur essendo diretto e chiaro, non scada nell’offesa gratuita o nel populismo verbale. Resta da vedere se questa speranza si tradurrà in realtà o se la tendenza attuale continuerà a dominare la scena politica italiana.