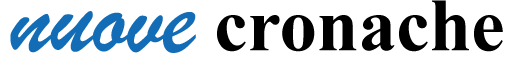L’eco dello sparo che il 10 settembre ha messo fine alla vita di Charlie Kirk rimbomba in tutti gli angoli del pianeta, divenendo il crinale di una linea di battaglia ideale, o piuttosto il momento “epifanico” rivelatore delle rispettive culture di riferimento. Le reazioni e le prese di posizione (che per taluni possono apparire sconcertanti) da parte di pseudo intellettuali più o meno organici e maître à penser del progressismo nazionale ed internazionale (si pensi ad esempio alle esternazioni di Friedman, Odifreddi, Saviano o Scanzi) degli scorsi giorni, mi appaiono tutto sommato assolutamente coerenti rispetto al “brodo culturale” da cui molti tra loro provengono e di cui si nutrono costantemente. L’atteggiamento medio di una serie di dichiarazioni provenienti dalla sinistra intellettuale a livello planetario è quello di trattare l’omicidio dell’attivista conservatore considerando l’atto una conseguenza quasi logica della “polarizzazione” dello scontro politico in atto, quasi a dire “se si pretende di difendere le proprie posizioni senza conformarsi all’opinione egemonica, è normale che qualcuno prima o poi ti spari”; si dà vita, in questo modo, ad un singolare paradosso logico secondo il quale in fondo la colpa degli omicidi politici è delle vittime che con le loro parole hanno “seminato odio”. In pratica la teoria è: “purtroppo al mondo ci sono persone che parlando convincono altre persone delle loro tesi intolleranti, e quindi è normale che qualcuno spari loro per ristabilire il dialogo e la tolleranza”. Questa distonia valoriale è figlia di una sorta di complesso di superiorità morale che appartiene ontologicamente alle sinistre nelle loro varie declinazioni, in quanto, fin dalle loro origini culturali più profonde, esse si sono auto qualificate come latrici di razionalità e giustizia. E’ chiaro che, per chi si ritiene l’interprete della razionalità e quindi della ragione, l’avversario politico altri non può essere dicotomicamente che “l’irrazionale e quindi quello che ha torto”, e questo aldilà di ogni dubbio, aldilà delle azioni, aldilà dei fatti. Peraltro, l’omicidio politico non è per nulla estraneo al DNA politico-dottrinario della sinistra, anzi ne è parte integrante e fondamentale; questo non vuol dire assolutamente che la violenza e gli omicidi maturati in ambito politico siano storicamente appartenuti solo a questa determinata parte ideologica, ma la teorizzazione dell’omicidio come legittima prassi dell’azione politica è un connotato peculiare della sinistra. Nel corso dei secoli la politica è stata sempre teatro di omicidi: Tiberio Sempronio Gracco venne ucciso a colpi di sgabello e non a pugnalate solo perché nel senato romano non era permesso portare armi, ma è con i primi pensatori socialisti, anarchici e protocomunisti che l’omicidio in quanto tale (non la violenza rivoluzionaria o la guerra, che sono state proprie anche di altre posizioni ideologiche) viene teorizzato come elemento organico all’agire politico. Nel 1876 gli anarchici tennero a Berna l’ultimo congresso della loro “Internazionale anti-autoritaria”; da questo che sembrava l“ultimo atto” del movimento anarchico (che decise allora di sciogliere il proprio coordinamento), nacque la cosiddetta azione rivoluzionaria dello “spontaneismo anarchico”, che diventerà il vero terrore d’Europa (e non solo) negli anni a seguire. Il ragionamento era semplice: la parola d’ordine era distruggere il potere, uccidere il tiranno, e il fatto sarebbe stato la migliore propaganda dell’idea; le azioni violente, gli omicidi politici avrebbero prodotto una sorta di proselitismo del sangue; la dottrina sarebbe stata spiegata alle masse con l’azione omicida del singolo. Certo, detta così, sembra una cosa più astratta che concreta, più uno slogan che un programma operativo in grado di generare azioni capaci di mettere a rischio il potere costituito; ma, da questa interpretazione del pensiero anarchico, venne fuori una lunghissima scia di sangue che lasciò sul terreno non personaggi minori, ma alcuni tra gli uomini più potenti dell’epoca. In nome della “propaganda del fatto”, furono vittime di attentatori solitari o di piccolissimi gruppi anarchici lo zar di Russia Alessandro II nel 1881, il presidente francese Sadi Carnot nel ’94, il presidente spagnolo Canovas del Castillo nel ’97, l’imperatrice Sissi d’Asburgo nel ’98; l’anarchico Gaetano Bresci uccise il re d’Italia Umberto I nel 1900 a Monza, precedendo di un anno l’azione del suo collega polacco Leon Czolgosz, che a Buffalo fece fuori McKinley, venticinquesimo presidente degli Stati Uniti d’America. Questo solo per parlare dei più noti. In effetti la lista dei personaggi con ruoli apicali passati a miglior vita per mano dallo “spontaneismo anarchico” deve necessariamente completarsi con almeno altri tre “cadaveri eccellenti” (per dirla alla Sciascia): qualche anno più tardi furono uccisi il re di Portogallo Carlo I e suo figlio nel 1908, e il re di Grecia Giorgio I nel ’13. L’Omicidio come “atto di propaganda” ossia come “agire politico” è quindi cosa profondamente diversa da un omicidio maturato in un ambiente politico o per ragioni politiche, come ad esempio furono il famigerato delitto Matteotti o l’uccisione di Marat ad opera di Charlotte Corday (due omicidi molto diversi tra loro, ma nessuno dei due con finalità propagandistiche). Il “Partito Socialista Rivoluzionario” fu una formazione di grande successo nata nel 1902 nella Russia zarista (i suoi membri verranno poi quasi completamente sterminati dai bolscevichi dopo la rivoluzione d’ottobre nel 1917), che riunì numerosi gruppi socialisti provenienti particolarmente dal mondo agrario. Nella prassi politica del Partito Socialista Rivoluzionario l’omicidio di ufficiali di governo e di uomini in vista dello zarismo ebbe un ruolo centrale, e, a tale scopo, il partito si dotò di una sezione deputata a questo compito, che prese il nome di “organizzazione di combattimento del socialismo rivoluzionario”; della sua attività omicida fecero le spese, tra i tanti, ben due ministri degli interni Dmitrij Sipjagin e Vjačeslav Pleve, il granduca Sergej Aleksandrovič, il governatore di Ufa Nikolaj Bogdavič. Sempre ad opera di un socialista rivoluzionario, nel 1911 a Kiev venne ucciso il ministro dello Zar Pëtr Arkad’evič Stolypin, che stava portando avanti una riforma agraria che avrebbe accontentato larga parte del mondo rurale, sottraendolo a tentazioni rivoluzionarie. Ma il largo utilizzo dell’omicidio come elemento dell’azione politica non è estraneo nemmeno alla sinistra di casa nostra. Le Brigate Rosse che, come Francesco Cossiga in maniera al solito acuta sottolineò spesso, non furono un organizzazione terroristica bensì un partito comunista armato, usarono l’omicidio politico, specialmente nella loro fase matura, come sistematico strumento di azione/propaganda politica; si pensi al caso Moro ovvero al, drammaticamente fuori tempo massimo, delitto di Marco Biagi. Omicidi con una specifica funzione, morti quasi didascaliche, che spiegano una teoria attraverso la pratica violenta. Archetipo dell’omicidio politico perpetrato nell’ambito di una strategia politico/propagandistica senza dubbio fu quello del filosofo Giovanni Gentile. In risposta all’appello alla concordia apparso sul Corriere della Sera a firma del filosofo di Castel Vetrano, Concetto Marchesi scrisse, in Svizzera, un articolo polemico contro Gentile ed i suoi inviti alla riconciliazione nazionale; l’articolo venne riproposto da vari fogli clandestini comunisti in Italia, ma al testo originale venne aggiunta (ad opera del dirigente comunista Girolamo Li Causi) una frase molto esplicita “Per i manutengoli del tedesco invasore e dei suoi scherani fascisti, senatore Gentile, la giustizia del popolo ha emesso la sentenza: MORTE!”. Una vera sentenza di morte in piena regola, che venne puntualmente eseguita a Firenze il 15 aprile del 1944 da parte di partigiani comunisti. L’episodio divise il fronte antifascista: parte del Comitato di Liberazione Nazionale toscano disapprovò il delitto, non dello stesso avviso fu il Partito Comunista Italiano. Infatti, il primo giugno del 1944, Palmiro Togliatti riprodusse su “Rinascita” l’articolo di Marchesi, facendolo precedere da una nota intitolata “Sentenza di morte” che recitava:«Questo articolo di Concetto Marchesi venne pubblicato nel numero 4 (marzo 1944) della rivista del partito comunista “La nostra lotta” che si pubblica clandestinamente nelle regioni occupate dai tedeschi. Esso venne scritto in risposta a un miserando e vergognoso appello di Giovanni Gentile alla “concordia”, cioè al tradimento della patria, apparso nel Corriere della Sera fascista. Poche settimane dopo la divulgazione di questo articolo, che suona come atto di accusa di tutti gli intellettuali onesti contro il filosofo bestione, idealista, fascista e traditore dell’Italia, la sentenza di morte veniva eseguita da un gruppo di giovani generosi, e la scena politica e intellettuale italiana liberata da uno dei più immondi autori della sua degenerazione. Per volere ed eroismo di popolo, giustizia è stata fatta». Tornando alla vicenda di Charlie Kirk, il sostanziale avallo postumo del delitto (non così diverso da quello di Togliatti nel caso Gentile) ad opera di una larga parte del progressismo globalista e delle sinistre nazionali ed internazionali, ben si inserisce nel solco di una tradizione che non rinnega l’omicidio come legittima prassi dell’azione politica. Per comprendere le vicende di oggi è sempre opportuno guardare alla Storia perché non c’è evento che non sia “intellegibile attraverso lo studio della sua genesi”. Questo principio vale per gli eventi quanto per le ideologie: la temperie culturale che oggi avvolge le sinistre mondiali è figlia delle sensibilità culturali che stratificandosi nel corso degli ultimi due secoli le hanno dato vita; quindi non devono apparirci per nulla anomale determinate posizioni che, come abbiamo qui illustrato, vengono da molto lontano.
di Sabino Morano