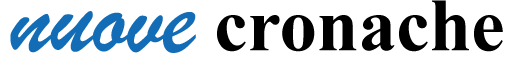Siamo lieti di ospitare l’Architetto Antonio Verderosa, figura di spicco nel panorama della pianificazione territoriale e urbanistica, con una profonda conoscenza delle dinamiche normative del Sud Italia. L’Architetto Verderosa vanta una lunga esperienza professionale focalizzata sulla pianificazione urbana a scala comunale, il restauro dei beni culturali e la rigenerazione ambientale, tematiche cruciali per il nostro territorio, caratterizzato da un elevato grado di sismicità e complessità idrogeologica. Non solo professionista sul campo, ma anche accademico: è stato Visiting Professor presso atenei come l’Università degli Studi di Salerno e Roma Tre, oltre a svolgere intensa attività di docenza in materia di procedure edilizie e sicurezza sui cantieri. La sua autorevolezza è riconosciuta a livello istituzionale: è Arbitro e Perito della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed è stato anche Consulente del Ministero delle Infrastrutture. L’Architetto Verderosa è inoltre autore di numerose e qualificate pubblicazioni e commenti specialistici che analizzano e anticipano gli sviluppi legislativi, come quelli sulla perequazione urbanistica e la semplificazione edilizia in Campania. Oggi, l’Architetto Verderosa è qui per analizzare un testo di cui è profondo conoscitore: la Riforma Urbanistica Regionale e l’impatto cogente del Regolamento n. 3 del 2025.
Architetto Verderosa, il Regolamento regionale n. 3 del 6 ottobre 2025, in attuazione dell’Art. 43-bis della L.R. Campania 16/2004, è stato introdotto come l’atto normativo urgente per superare l’attuale “empasse” urbanistico. Qual è il giudizio sul precedente quadro normativo e cosa segna questa riforma come svolta strategica?
Il Regolamento, abrogando il precedente R.R. n. 5/2011 , riconosce implicitamente il fallimento del suo approccio prevalentemente procedurale, il quale ha causato frammentazione e inerzia amministrativa, determinando “mostruosi ritardi”. La nuova norma segna una svolta strategica, imponendo un modello di pianificazione orientato alla sostenibilità ambientale (Art. 2) e urbanistica (Art. 5). Il fine ultimo è l’indirizzo definitivo della Campania verso il principio di Consumo di Suolo Zero , ponendo la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente come strategia prioritaria in netta rottura con l’espansione territoriale passata.
In che modo la riforma modifica la struttura della pianificazione comunale (PUC)? E come si affrontano i ritardi cronici dei procedimenti amministrativi?
Il modello di pianificazione comunale (PUC) è ora basato sulla struttura duale:
• Il Piano Strutturale Urbanistico (PSU), di natura strategica e con efficacia a tempo indeterminato.
• Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) (Allegato B), con funzione regolativa.
Questa impostazione, definita dall’Art. 28, decreta finalmente il fallimento dei Piani Operativi (PO) come strumenti separati, la cui funzione è ora assorbita e semplificata nel RUE. Inoltre, l’Art. 20 conferma l’obbligo di approvazione contestuale di PSU e RUE. Per contrastare l’inerzia, sono stati introdotti termini perentori e decadenze (Art. 6). Ad esempio:
• L’amministrazione ha centoventi giorni, a pena di decadenza, per valutare e recepire le osservazioni (60 giorni).
• L’approvazione consiliare deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, a pena di decadenza.
Lei ha dettagliato i nuovi termini perentori. In Campania, si stima che mediamente l’ottenimento di un parere sullo strumento urbanistico richieda circa 18 mesi, un tempo che paralizza lo sviluppo. Il nuovo Regolamento impone che l’approvazione consiliare avvenga entro 60 giorni. Questa drastica riduzione è davvero credibile o rischia di essere un obiettivo astratto?
La differenza tra i 18 mesi di paralisi e i 60 giorni per l’approvazione consiliare è esattamente il cuore della riforma. Non si tratta solo di un obiettivo, ma di un vincolo giuridico rigoroso. L’Art. 6 introduce le Decadenze Procedurali. Nello specifico, l’approvazione consiliare deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, a pena di decadenza. Questo meccanismo sanzionatorio è inedito e mira proprio a trasformare la storica inerzia in certezza operativa , rendendo la rigorosità procedurale la chiave per superare i blocchi temporali endemici.
Quali implicazioni ha l’equiparazione delle classificazioni territoriali e il ruolo della Valutazione di Incidenza (VIncA) nel nuovo assetto?
Un punto fondamentale è l’equiparazione netta e vincolante (Art. 15) delle nuove classificazioni territoriali (territorio urbanizzato e territorio rurale) alle Zone Territoriali Omogenee (ZTO) del D.M. 1444/1968. Dal punto di vista ambientale, il principio di sostenibilità (Art. 2) è rafforzato dall’obbligo di avviare VAS e VIncA contestualmente al procedimento di pianificazione. Questa previsione, in linea con la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sentenza n. 4135/2021) , eleva la VIncA a requisito di validità ab origine del titolo abilitativo, superando l’impostazione che la considerava una mera condizione di efficacia.
Come la riforma spinge concretamente verso la rigenerazione e il riuso del patrimonio edilizio, rendendo il Consumo di Suolo Zero economicamente vantaggioso?
L’intero impianto normativo promuove il riuso e la riqualificazione delle aree edificate attraverso l’adozione di modelli insediativi compatti. L’Art. 16, comma 3, impone una rigorosa priorità al riuso del patrimonio esistente e all’utilizzo di suoli già impermeabilizzati, limitando in via residuale l’impiego di nuove aree permeabili. Questa strategia è sostenuta da precisi bonus e incentivi volumetrici:
• Fino al 35% per la demolizione e ricostruzione.
• Fino al 50% per la delocalizzazione da aree ad alto rischio (idrogeologico, sismico o vulcanico), subordinato all’acquisizione dell’area liberata al patrimonio comunale.
• È previsto anche un incremento volumetrico fino al 20% per la ristrutturazione senza demolizione.
Inoltre, vengono utilizzati strumenti come i comparti edificatori (Art. 21) per formalizzare la perequazione urbanistica, vincolando i diritti edificatori a essere utilizzati esclusivamente all’interno del territorio urbanizzato. Si aggiunge l’esenzione da oneri per interventi sociali (Art. 5, comma 12).
Architetto, nonostante l’approccio dettagliato, lei ha sollevato alcune criticità. Quali aspetti del Regolamento meritano ancora un chiarimento o un rapido recepimento?
Ci sono due aspetti rilevanti:
1. Si rileva la mancanza di una disciplina esplicita sulle opere edilizie minori.
2. Esiste una criticità giuridica sull’immediata applicabilità della norma relativa al cambio d’uso nel territorio rurale, che richiede il celere recepimento nei PUC.
Lei sottolinea che la piena operatività del Regolamento è un “imperativo categorico”. Qual è, a suo avviso, la principale minaccia alla tempestiva attuazione?
La principale minaccia non è la norma in sé, ma l’apparato amministrativo. L’efficacia della riforma, pur poggiando su solidi vincoli giuridici e decadenze procedurali (Art. 6) , rischia di scontrarsi con la realtà di Enti preposti all’espressione di pareri ingolfati e fortemente burocratizzati. È in questo “collo di bottiglia” che si annida il rischio di vanificare la riforma. Pertanto, l’urgenza si traduce nell’imperativo di sburocratizzare e potenziare gli Enti consultivi , garantendo che la spinta normativa della Regione non si infranga contro un apparato incapace di processare con la dovuta celerità i processi pianificatori. Inoltre, è urgente che la Regione fornisca concreta chiarezza sui masterplan strategici (PIV, PTCP) , che non devono restare “meri contenitori vuoti” ma devono essere dotati di strumenti operativi e finanziari.
Architetto, lei ha evidenziato che l’efficacia della riforma poggia su solidi vincoli giuridici. Tuttavia, qual è il rischio concreto che questi meccanismi normativi, come le decadenze procedurali e la preventività della VIncA, vengano di fatto vanificati dalla persistente lentezza e dall’inefficienza della macchina burocratica regionale, minando il successo della riforma?
Questo è il vero “collo di bottiglia” e la minaccia più grande. Sebbene il Regolamento imponga la preventività della VIncA (Art. 2) e introduca decadenze procedurali , l’obiettivo di trasformare l’attuale stallo in una stagione di rigenerazione urbana e Consumo di Suolo Zero dipende dalla capacità di quegli stessi Enti di adeguarsi ai nuovi ritmi. Purtroppo, la realtà è che gli Enti preposti all’espressione di pareri sono ingolfati e fortemente burocratizzati , e la spinta normativa rischia di infrangersi contro un apparato incapace di processare con la dovuta celerità i processi pianificatori. La limitazione giuridica alle varianti (Art. 9, comma 3) e la flessibilità di strumenti come il Programma Operativo (PO) non possono da soli sopperire a questa lentezza amministrativa
Architetto Verderosa, la ringrazio per questa analisi dettagliata sulla riforma urbanistica.
Grazie a lei. La piena operatività del Regolamento è la condizione necessaria per trasformare la paralisi urbanistica Campana in una stagione di sviluppo sostenibile, certo e trasparente.
di Mat. Lib.